La deriva conformista della politica post-istituzionale
Diritto e libertà
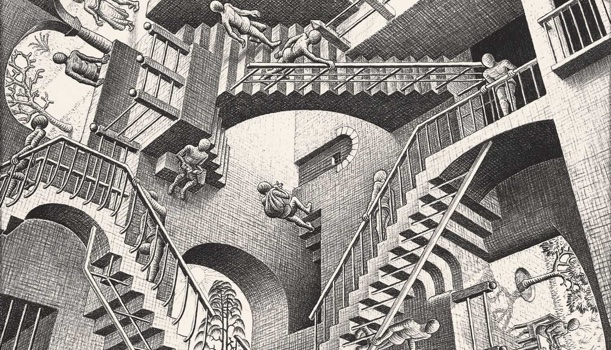
Sappiamo tutti che gli esponenti politici amano dire spesso delle “bufale” e sovente, anche, “cose sgradevoli” nei confronti dei competitori, trasformando questi ultimi in “avversari” da far fuori. Sicché, tra le “bufale” e le “sgradevolezze” la competizione elettorale assume le forme ora di un circo di quart’ordine, ora di un ring sul quale i contendenti danno colpi sopra e sotto la cintura pur di abbattere l’avversario. Nell’uno e nell’altro caso il fine è ottenere il consenso o l’ovazione degli spettatori-elettori. E questo pur di vincere, senza pensare al dopo, quando verrà il tempo di formare un governo.
Il fenomeno è liquidato dagli organi di informazione con una espressione che viene ripetuta con la disinvoltura tipica delle frasi innocue: “siamo in campagna elettorale”; insomma è un po’ come fare spallucce quando assistiamo a comportamenti di quotidiana sciatteria o inurbanità. Ebbene, quella frase non è affatto innocua; al contrario! E’ gravissima. Perché?
La campagna elettorale è la premessa comunicativa destinata ad orientare il consenso dei cittadini verso la classe politica e costituisce l’origine della rappresentanza parlamentare. I contenuti comunicati, quindi, sono quelli che, avendo orientato il consenso, legittimano la composizione e l’articolazione numerica del Parlamento. Allora, se contenuti comunicati e legittimazione rappresentativa costituiscono un nesso inscindibile, ne segue che bufale e sgradevolezze vanno a costituire la base di legittimazione della rappresentanza parlamentare, cioè della classe politica chiamata a governare.
Quella frase è gravissima anche per un’altra ragione. Perché sta a significare che il ceto politico ritiene che il cittadino elettore, nei grandi numeri, sia particolarmente sensibile ad un linguaggio spesso colorito, talora anche aggressivo, e non sappia distinguere, o comunque non sia attratto dalla distinzione, tra ragionamenti e proposte serie e promesse o proposte del tutto inattendibili. Come dire che la maggior parte dei cittadini non sarebbe in grado di riflettere e ragionare; sia, cioè, disabituata a pensare. Abbia quindi bisogno di un linguaggio che, per la forma e i contenuti, ne provochi la mera reattività; un linguaggio a effetto. Un linguaggio che vada dritto alla “pancia”.
Se le cose stanno così, allora vuol dire che il cittadino elettore, genericamente inteso, è considerato dal ceto che pure ne chiede la legittimazione di governo, privo di “testa” o comunque disabituato ad usarla. In altre parole, il ceto politico chiede legittimazione ad un ambiente umano divenuto incapace di usare la testa! Non per stupidità, ma per atteggiamento comportamentale. Ne fa un affresco estremamente incisivo Simonetta Bisi in un volumetto comparso lo scorso anno (Bordeaux 2017) dal titolo significativo: La maggioranza sta. I conformisti del XXI secolo.
In definitiva, il percorso elettorale e il processo di legittimazione politica si giocano su di un piano che è esclusivamente discorsivo-comunicativo con finalità reattive. E il Novecento, già nella sua prima metà ne fece significativa esperienza; ma mi limito qui alla seconda metà, nella quale si sono consolidate le democrazie rappresentative. Il loro fulcro sta nella “credenza” nelle Istituzioni e nell’ordinamento giuridico da parte dell’ambiente sociale. Poiché è l’esistere di una tale “credenza” che trasforma un generico ambiente umano in una “società”.
Il tema della “credenza” era stato messo in luce all’inizio del secolo scorso da Weber, quando affermava che la legittimazione del potere di governo fondata sul principio di legalità presuppone la “credenza nell’ordinamento” da parte della collettività. In realtà, ciò che la traduzione italiana del testo weberiano indica come “credenza” nell’originale tedesco è Glaube, che vuol dire propriamente “il credere”, che richiama l’ideale tipicamente tedesco del valore della legge in quanto legge. La “credenza”, nel lessico italiano, evoca piuttosto un atteggiamento mentale irriflesso, assai lontano dalla fondatezza razionale del “credere” tedesco. E’ un particolare che servirà tra poco.
Sempre in tema di potere politico, Weber aggiungeva ancora un’altra osservazione, che si può riassumere così: colui che ha il potere economico tende a trasformare tale potere in potere politico. Tale passaggio, che ha segnato una parte significativa della storia recente delle democrazie occidentali, determina una duplice conseguenza. La prima è concettuale, in quanto rende evanescente la distinzione di piani tra sfera “pubblica” e sfera “privata”. Nella sfera pubblica, l’esercizio del potere ha per obiettivo il governo della società, cioè il cosiddetto “bene comune”; nella sfera privata, invece, il potere persegue il profitto economico, vale a dire la soddisfazione e negoziazione di “interessi” secondo istanze e valutazioni personali e dunque “private”.
Nella evanescenza attuale della distinzione, legata alla prospettiva consolidatasi con la globalizzazione finanziaria e mercatistica, si annida una seconda conseguenza che rinvia alle tesi svolte da due sociologi di Yale, Lasswell e Kaplan, negli anni ’50. E tale seconda conseguenza riguarda proprio quel piano discorsivo-comunicativo cui ho fatto cenno all’inizio di queste righe. Mi riferisco alla distinzione tra due modelli comunicativi: “propaganda” e “pubblicità”.
Quest’ultima orienta, come è noto, le scelte dell’individuo; riguarda dunque la sfera nella quale operano gli interessi privati. La prima, al contrario, è quella forma comunicativa che veicola i simboli ideali che mettono in forma un progetto sociale, riducendo lo spazio d’incertezza attorno a prospettazioni valoriali controverse, con il fine di ottenere fiducia istituzionale. Se allora si mette in relazione la propensione politica del potere economico, segnalata già a suo tempo da Weber, con i codici comunicativi “propaganda – pubblicità”, ci si avvede di una pericolosa sovrapposizione. In particolare, il codice comunicativo “pubblicità”, tipicamente economico, prende il posto di quello strettamente politico, “propaganda”; ne segue che la fiducia nell’Istituzione, che è una finalità propriamente politica, sarebbe realizzata attraverso il ricorso al codice economicistico della pubblicità.
L’offerta politica assume la forma comunicativa che promuove un “prodotto” da supermercato, trasformando il cittadino in un consumatore che sceglie questo o quel “prodotto” a seconda della propria convenienza o gusto del momento. Viene meno il senso del “disegno politico” e della “cosa pubblica” e la “credenza” nelle Istituzioni diviene una marginalità inutile. Ecco il punto da sottolineare: se il detentore del potere politico è un soggetto dominante nel campo economico e la strategia di stabilizzazione del suo potere politico consiste nell’uso della pubblicità commerciale come mezzo della comunicazione politica, in ciò è la radice più profonda del cosiddetto “conflitto di interessi”. Esso, infatti, non va inteso solamente come interferenza della sfera economica in quella politica, ma, più propriamente, come incidenza sui processi che formano il consenso ed inducono alla fiducia.
In altre parole, nei processi istituzionali si insinua una logica di tipo individualistico – imprenditoriale, che conduce ad una destrutturazione sistemica del rispetto per le Istituzioni in quanto tali, giacché esse perdono qualsiasi valenza politico – simbolica. La tenuta sociale, finché dura, dipende così da un abito mentale genericamente diffuso tra i consociati fondato sulla interazione e soddisfazione, a diversi livelli, di interessi privati, più o meno di sistema, e imputabili a soggetti singoli, a gruppi, a lobbies.
E’ in un tale contesto che si avverte la differenza tra la “credenza” italiana nelle istituzioni e nella legalità ed “il credere” tedesco nella legge. La credenza è legata ad una abitudine mentale che si diffonde e si afferma in una certa epoca. E se per abitudine si pensa che “tutto è mercato”, tale abitudine distrugge il senso della “cosa pubblica” e con questo il significato di “bene comune” e delle Istituzioni. Il credere nella legge, invece, è il tener fermo il valore dello Stato come ente politico e giuridico, senza il quale non esiste società. Quale sia la forza di tale posizione nel mondo tedesco lo mostrava anni or sono, all’indomani della seconda guerra, Ernst Forthoff, il quale sosteneva che l'obbedienza rigorosa dei tedeschi alle leggi si radicava nella diffusa convinzione (non “credenza”) che, quale che fosse il loro contenuto, esse fossero ben fatte da valenti giuristi, in quanto strutture regolative (Vefassungsprobleme der Sozialstaates, Munster 1954).
Certo, oggi le società italiana ed europea non vivono più quel fermento di valori politici che seguì la tragedia della guerra e che dette vita al consolidarsi delle democrazie rappresentative; tuttavia, l’attuale perdita del significato delle istituzioni, quale si mostra nella crescente debolezza dei sistemi rappresentativi, è il sintomo di qualcosa che va oltre l’abitudine alla pace. Esso mette in luce il liquefarsi dell’idea di democrazia del secondo ‘900 a causa di generazioni di praticanti la politica, assolutamente impreparate culturalmente alla concezione del governare, perché formate allo schema operazionale dell’economicismo finanziario.








