Governare, ovvero l'irrisolta questione italiana
Diritto e libertà
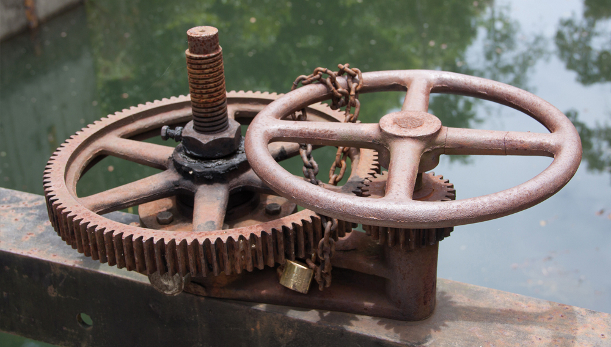
Come è del tutto evidente, la situazione politica italiana non accenna in alcun modo ad approdare verso svolgimenti ordinati. Sono ormai quasi trent’anni che non si riesce a dare risposta al problema del governo. Finita – per la determinazione con la quale la magistratura mise fine alla degenerazione alla quale era giunto il finanziamento illecito della politica – la stagione dei “partiti”, ci si illuse che, modificando il sistema elettorale, sarebbero cambiate le cose.
È accaduto solo che, in luogo dei vecchi “partiti”, sono subentrate nuove “formazioni”, presto divenute non meno esigenti dei primi. Semmai più arroganti. Per la più diretta investitura popolare dei loro capi. E mentre un tempo chi governava (pentapartito nella forma ultima) era espressione di una “mediazione” che aggregava metà degli elettori, in quella nuova (grazie ai meccanismi maggioritari) bastava ora un consenso più basso (che dunque circoscriveva gli “influenti”: la parte di paese temporaneamente decidente).
Con due ulteriori elementi di novità. La prima. La formazione del governo non avveniva in precedenza su “obbiettivi”, ma su “metodi” (la DC era il pilastro di una maggioranza interclassista, orientata alla mediazione). E dunque rispondeva meglio alla possibilità di dare attenzione “selettiva” e “progressiva”, secondo urgenze, alle istanze. Ora tendeva a proporsi su “obbiettivi”: era perciò di principio molto più sollecitante e divisiva.
La seconda. In passato le mediazioni si consumavano in una doppia fase. La prima era interna ai partiti (portava alla individuazione di “rappresentanti” e linee politiche). La seconda avveniva tra i partiti (portava alla formazione di un governo). Ora esse tendevano a sparire. Il leader “interpretava” aspirazioni e sentimenti. Li ordinava nel merito e nel tempo e li traduceva in linee di azione. In realtà, dovrei dire, tentava solo, tale era (e resta) il coacervo inestricabile delle possibili interferenze ostative. È avvenuto con tutti coloro che si sono avvicendati “elettivamente” al governo dopo il 1994.
A parte il sistema elettorale (fatto e rifatto in ragione degli interessi di chi vi provvedeva, anche con esiti non sempre corrispondenti alle attese), il resto delle regole del gioco (forma di governo fissata nella costituzione) è rimasto immutato. Come immutata è rimasta (perché non può venir meno) la necessità di risorse per la politica. Non si è avuto mai il coraggio di dirlo. E perciò anche la capacità di tradurlo in regole trasparenti fino in fondo.
Allo stesso modo, non è mai venuta meno (perché anch’essa connaturata alle cose) l’aspirazione dei singoli a vedere premiati i “propri” interessi innanzitutto. Con la conseguenza del crescere esponenziale di una pratica di “scambio”, che ha trasformato le decisioni pubbliche in decisioni nell’interesse dei finanziati (conservazione del potere) e dei finanziatori: non solo i “grandi”, interlocutori diretti del governo, ma progressivamente tutti, anche coloro che aspiravano ad atti amministrativi di rilevanza individuale, come un permesso o una licenza. Sono divenute endemiche le ingenue “raccomandazioni”. È divenuta endemica la corruzione (anche per la fila da osservare a uno sportello).
È del tutto ovvio che la generalizzazione che ho fatto è grossolana. E che si potrebbero fare molti distinguo. Ma il punto non è se l’analisi è grossolana (come è). Il punto è se essa è anche stravolgente della realtà (e non credo lo sia). Nonché della percezione (generale) che se ne ha (del che non ho praticamente dubbi).
È una lettura impropria quella che vorrebbe distinguere una “prima” repubblica dalle successive. Per quanto i sistemi elettorali siano sicuramente elemento rilevante della forma materiale di governo, è vero anche che questa seconda si lega in realtà ad un complesso di fattori (legislazione, amministrazione, giurisdizione) molto più ampio ed incidente. E nella nostra repubblica essi non sono mai cambiati. Sono quelli disegnati nella Carta del 1948. Noi siamo nella prima (e mai venuta meno) repubblica.
Quando allora osserviamo ciò che accade, non ha molto senso farlo, se si è ancora dell’opinione che la forma di governo in essa disegnata sia quella ancora appropriata ai tempi. Quando Salvini afferma di operare in forza di una legittimazione popolare dice una cosa vera, così come quando afferma che tale legittimazione manca ai magistrati. Ma quando i magistrati gli oppongono che ciò è per volontà del costituente, dicono una non meno evidente verità.
Il fatto è che il nostro è un sistema costituzionale figlio di tempi superati. E che la pretesa, a sua volta, di chi è in momentanea maggioranza di sottrarre la propria azione ad ogni limite risponde ad una visione dell’autogoverno inaccettabile. Se lo rappresenta come azione “di parte” e non come azione “collettiva”. Ogni “maggioranza” è tale se lo è all’interno di un “sistema”, che le riconosce capacità di “orientamento”, non di “dominio”. Un equilibrio “politico” (di una collettività che si autogoverna) vive di “maggioranza” e “minoranze”, che si danno reciproca attenzione (ciascuna cosciente della costante “provvisorietà” della loro consistenza). Se non è così, si esce da una visione “politica”, per consegnarsi ad un sovrano. Lo scontro è figlio di assetti. Ed anche del modo nel quale gli assetti in questione sono “gestiti”. In un sistema politico non conta solo il “disegno”. Conta, molto di più, il “come” il disegno viene storicamente attuato. Ed è di ogni evidenza come lo stesso disegno (quello della nostra Costituzione) abbia ricevuto – nei primi 25/30 anni di vigenza – una interpretazione “cauta” (orientata da una forte propensione di tutti all’autocontrollo). E in quelli successivi una interpretazione “estremizzante” (orientata a sfruttare sino in fondo ogni possibilità offerta).
Della forma attuale di governo non funzionano molte cose. Non funziona l’assetto di governo, nella parte che disciplina le procedure e dunque i tempi necessari per reagire tempestivamente alle occorrenze (si pensi all’uso/abuso del decreto legge). E non funziona nella parte che ignora che a “decidere”, a sciogliere (amministrativamente e giudiziariamente) il nodo concreto non è la regola astratta (la legge), ma un “uomo” (fallibile e discutibile). E che dunque non può bastare la “legge” per governare le cose.
Il governo è un fatto complesso che (in un sistema di autogoverno, quale quelli democratici aspirano ad essere), per essere efficace, ha bisogno di mediazioni molteplici, che ne accompagnino l’azione. Dalla ideazione di essa al suo esito nel provvedimento finale. Il che può aversi solo a valle di una riflessione molto attenta che incida non solo sul suo “disegno”, ma anche sulla “pratica” che ne viene.
Le cose dimostrano che né il disegno vigente, né la pratica che se ne fa sono efficaci. Permettono due affermazioni (quel che faccio è giusto perché lo faccio nel nome di tanti; quel che faccio è giusto perché ne ho il potere/dovere) entrambe vere, ma entrambe sostenute da una logica “gerarchica” assoluta. Come se dicessimo: per mandato di una maggioranza elettorale, si può anche rubare o uccidere. O anche: per occasione (rivestire una funzione pubblica), si può anche esplicare un potere “tirannico” (totalmente autoreferenziale). Nessuna delle due affermazioni sarebbe compatibile con un ordine di governo accettabile. Almeno, da chi avesse a cuore (come credo ancora tutti noi) la propria “libertà”. La quale resta insuperabilmente uno “spazio certo” di azione, che deve convivere con altri “spazi” non meno confinati di azione.
I nodi arrivano al pettine. L’arrogante gestione del potere politico ha generato sacche molteplici di privilegio, mantenute in vita con un gioco di scambi (clientele). Esaurita la possibilità del quale (per esaurimento delle risorse), gli esclusi finali si sono rivoltati. In Italia. In Europa. Nel Mondo. Ai molti (e ovviamente diversi per drammaticità) livelli. Ma la direzione impressa al “cambiamento” rischia di imboccare una deriva: quella che ha sempre accompagnato la esasperazione delle tensioni. Veleggiamo verso l’autorità. Di chi? È difficile dire. Ma è inesorabile che accadrà.
E c’è un nuovo pericolo. La sempre maggiore interconnessione delle economie ha fatto maturare insofferenza anche oltre gli assetti “interni”. Tocca ormai anche quelli internazionali, divenuti a loro volta molto più mobili e fragili, dopo la fine dell’equilibrio fissato a Yalta. Non v’è dubbio che si siano venute formando, anche in proposito, consorterie (politico-economiche) che possono apparire (e che forse sono) “escludenti”. Ma è parimenti indubbio che politiche “dirompenti” non giovano di certo a cambiare nella direzione sperata. Possono solo fare saltare il banco. Quando è necessario invece “ricostruire” equilibri. Che hanno bisogno di ordinamenti “complessi” e non linearmente “gerarchici” (come gli attuali).
Nessun paese sviluppato e tuttavia “modesto” per dimensioni (come l’Italia) può permettersi un orizzonte “isolato”. Non lo ha potuto mai. Meno ancora lo potrebbe oggi. In un tempo di relazioni (di necessità) “senza confini”. Sono state perciò, e sono, indispensabili alleanze. Ma un conto è sceglierle in una direzione “sostenibile” (come compresero Cavour e i politici della cd. prima repubblica). Un conto in una direzione ottusa nelle premesse e senza uscita nelle prospettive (come accadde a Mussolini). Non si può cercare un nuovo assetto “liberale” (quale necessario per un Europa da ricostruire) accodandosi a chi la libertà, in casa sua, mostra di disprezzare.
Occorre molta prudenza. Occorre non demonizzare ciò che accade. Ma comprenderlo. E accompagnarlo verso esiti “rigeneratori” (di autogoverno e democrazia) e non “degeneranti” (verso tirannidi, non importa se “oscurantiste” o “illuminate”, come talora possono anche essere: importante, diceva Cicerone, non è avere un buon re, importante è non averne alcuno). Chiudersi a difesa di un passato indifendibile non può che favorire la degenerazione. I governi che si sono insediati (e quelli che, sulla scia, inesorabilmente verranno) hanno molte ragioni. Sbagliano nei metodi. Amano le spicce. Quando ciò che va deciso è invece tremendamente complesso. Ed è alla coscienza di questa complessità che occorre riportarli. Con il ragionamento, non con la supponenza.








