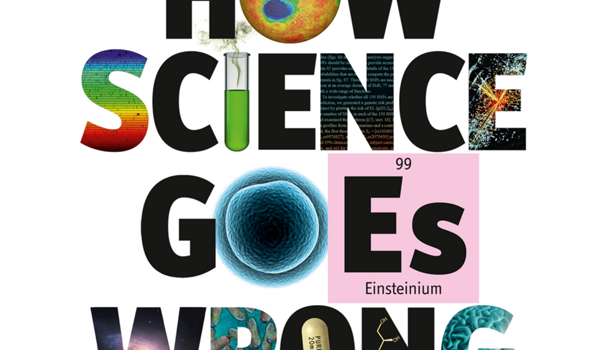How politics goes wrong
Scienza e razionalità
Anna Meldolesi ospita, nel suo blog sul Corriere, un interessante scambio di opinioni a valle dell’ormai celebre approfondimento dell'Economist dal titolo “How science goes wrong”, sugli errori della scienza e i gravi limiti dei processi di verifica delle ricerche scientifiche. Sul tema sono intervenuti Elena Cattaneo e Paolo Bianco.
Quest’ultimo intitola il suo intervento “How economy goes wrong”, ed è a lui che vorrei, nel mio piccolo, provare a rispondere. Il centro del ragionamento di Bianco è in questo passo, che cito per intero per non rischiare di banalizzarne il contenuto:
l’epoca del grande successo della scienza, dice lo stesso articolo dell’Economist, è quella che comincia dalla fine della seconda guerra mondiale. Quell’epoca è segnata e definita da alcuni fatti precisi: è l’era di Vannevar Bush e del finanziamento pubblico alla libera ricerca biomedica, nonché del finanziamento industriale a ricerca e sviluppo industriale. E’ l’epoca in cui la scienza è “bene comune” e per questo finanziata con denaro pubblico. E’ l’epoca che eredita dal progetto Manhattan l’idea che la scienza sia strategicamente utile, in tempi di guerra calda e in tempo di guerra fredda. Nessuno coglie, neanche l’articolo dell’Economist, il punto ineludibile che quel periodo finisce già agli inizi degli anni Ottanta, ed è non da quell’epoca, ma esattamente dalla sua fine, che quel che l’Economist descrive nasce. Così come l’economia mainstream è sostituita dal pensiero “neoliberal”, la pubblicazione è sostituita progressivamente dal brevetto, il finanziamento pubblico alla scienza si avvia alla rottamazione, la scienza si commercializza, si giustifica solo in quanto utile o “translational”, diventa oggetto di misura commerciale (che altro crediamo che siano impact factor e H-index, se non sistemi metrici convertibili in valore finanziario?). Più in generale, l’epoca in cui il sapere è un valore umano e civile, compatibile con la sua rilevanza strategica militare, e funzionale allo sviluppo industriale ma da questo indipendente, sfuma in quella in cui il sapere è tutt’al più utile all’innovazione commerciale direttamente perseguita in ambito accademico, o non è.
L’epoca della scienza “bene comune” non è nata con la fine della seconda guerra mondiale. Piuttosto, è uno dei paradigmi che ha condotto a quella guerra. Le ricerche di Mengele erano finanziate con denaro pubblico. Altrove, lo erano quelle di Lysenko, che ha lavorato ininterrottamente e coerentemente dagli anni ‘30 agli anni ’60. Sia prima, quindi, che dopo la seconda guerra mondiale. Erano proprio quelli i tempi in cui la ricerca era strategicamente utile, in cui il sapere era un valore umano e civile compatibile, ma anche subalterno, alla sua rilevanza strategica. Tra un regolatore pubblico che finanzia, in nome del bene comune, Mengele e Lysenko, e il mercato che attribuisce un “valore commerciale alla conoscenza”, personalmente mi tengo ben stretto il secondo.
L’idea che le degenerazioni illustrate dall’Economist siano figlie dei tempi, di un certo pensiero economico o di una ideologia dominante è un modo, in fondo, per affermarne l’ineluttabilità. Proprio quello di cui non abbiamo bisogno. Come per contrastare le concentrazioni monopolistiche esistono le legislazioni antitrust, molto più efficienti e a buon mercato di un ritorno all’economia pianificata, allo stesso modo i fenomeni descritti dall’Economist devono essere analizzati, spiegati e contrastati ferocemente nella loro concretezza ed attualità, tanto dal mondo scientifico che dai regolatori pubblici.
Facciamo un esempio: quando si dice che “la pubblicazione è sostituita progressivamente dal brevetto” - ma l’Economist parlava dei pericoli del publish or perish, non del patent or perish - dovremmo tenere a mente che proprio il brevetto è il più classico degli esempi di valore della conoscenza imposto non dal mercato, ma dal regolatore pubblico. E proprio in nome della tutela di un “bene comune”: la protezione della proprietà intellettuale è ritenuta infatti un irrinunciabile incentivo all‘innovazione. Ecco un buon argomento di discussione: la legislazione che protegge la proprietà intellettuale e le attribuisce arbitrariamente un valore commerciale è davvero un incentivo o piuttosto un disincentivo all’innovazione e alla diffusione della conoscenza? E quanto di ciò che racconta l’Economist è figlio di quella legislazione o almeno dei suoi aspetti più paradossali? Forse i tempi sono maturi per cominciare a parlarne.
Così come è il caso di cominciare a parlare del confirmation bias, e delle distorsioni che produce dal momento in cui alle case farmaceutiche è consentito di scegliere di pubblicare solo i risultati dei trial che ritengono utili all'autorizzazione di un nuovo farmaco. E via discorrendo, di carne al fuoco ce ne è davvero tanta. L’obbiettivo dovrebbe essere quello di ottenere regole migliori, non quello di imporre, chissà come poi, un diverso sistema di valori, peraltro discutibile. In ogni caso, torneremo sull’argomento nel prossimo numero di Strade.
- Questo post è stato pubblicato contemporaneamente anche su Prometeus Magazine.