Fondi sovrani e assalti alle diligenze. Confronto improbabile tra Norvegia e Italia
Istituzioni ed economia
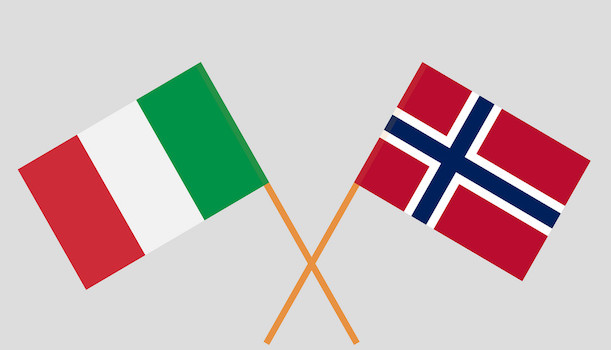
In questo articolo cercheremo di tracciare un confronto improbabile tra l’Italia e la Norvegia basato sulla responsabilità politica, l’etica pubblica e la trasparenza dell’azione di governo. Il giorno di Natale del 1969 la Norvegia si svegliò con la scoperta di immensi giacimenti di petrolio nel mare del Nord: circostanza indubbiamente fortunata, che avrebbe trasformato in uno dei maggiori produttori di petrolio un paese fino a quel tempo dedito prevalentemente ad attività economiche primarie (allevamento e pesca). Dall’inizio dello sfruttamento dei giacimenti, il PIL pro-capite norvegese è cresciuto, in 40 anni, del 2.300% (un tasso annualizzato dell’8%) fino ai 68 mila dollari del 2019: il quarto reddito pro-capite al mondo.
Verso la fine degli anni ’80 i politici norvegesi cominciarono a chiedersi quale fosse l’uso ottimale dell’ingente output dell’attività estrattiva e decisero di creare un fondo statale per la gestione dei surplus generati dalla vendita del petrolio, che era ovviamente una risorsa pubblica il cui sfruttamento era riservato a operatori pubblici. Il fondo sovrano vide così la luce nel 1990.
Dai 44 miliardi di dollari del 1998 (quando il fondo si diede un’impostazione più “attiva”, non limitandosi più ad investire in bond governativi) ha raggiunto in 20 anni un valore aggregato superiore a 1.100 miliardi (con un incremento annualizzato del 6%) ed è oggi il primo fondo sovrano al mondo.
La ratio di quella scelta era duplice. Anzitutto, certamente, creare un polmone di liquidità per assorbire la volatilità del prezzo del barile che inevitabilmente, in assenza di efficaci meccanismi regolatori, avrebbe finito per riverberarsi con le sue oscillazioni sulle entrate del Paese, propagando shock di natura esogena. Ma al fondo di quella intuizione era anche un’altra motivazione, attinente all’etica della responsabilità politica: si riteneva, infatti, che godere di un benessere tanto inaspettato fosse una fortuna che non dovesse rimanere esclusiva di una generazione. Che ai cittadini futuri non si dovesse quindi negare il beneficio di ricchezze in fondo appartenenti al paese. Il petrolio è una risorsa fenomenale – si pensava – ma un giorno si esaurirà. Dilapidarla per finanziare i consumi di una generazione (o magari due) sarebbe un atto di egoismo, profondamente ingiusto verso chi verrà dopo.
Il governo norvegese potrebbe oggi in teoria liquidare gli asset del Fondo Sovrano distribuendo oltre 200mila dollari a ogni cittadino, inclusi i neonati. Pensate: una famiglia norvegese di quattro persone riceverebbe 800 mila dollari. Oppure potrebbe azzerare le tasse per dieci anni, o ancora finanziare programmi di spesa pubblica del tutto inimmaginabili. Non male. Un governo con un programma simile raggiungerebbe vette di popolarità senza precedenti, garantendosi la rielezione per i prossimi 20 anni, giusto? O forse no.
In realtà, in Italia abbiamo la tendenza a ragionare con la nostra cultura latina, basata sulla separazione tra la convenienza personale (o familiare) e il bene della collettività mentre forse i cittadini norvegesi non si sentirebbero tranquilli se lo Stato trasferisse ai privati la ricchezza pubblica. È una sfumatura forse paternalistica di socialismo, che riconosce allo Stato un’etica delle scelte superiore rispetto ai suoi cittadini, mentre nella cultura liberale si tende invece a pensare che – rispetto alla mano pubblica – gli individui sappiano fare uso migliore delle risorse e che la ricchezza utilizzata dai privati per il proprio benessere personale detenga un potenziale più elevato di creare altra ricchezza per la collettività, per il tramite della libera iniziativa imprenditoriale. Negli USA, ad esempio, non avrebbero dubbi al proposito.
Poi c’è l’Italia. Dove non c’è una cultura liberale, ma neppure un socialismo paternalista alla norvegese. Il paese in cui politici e commentatori hanno salutato l’accordo sui Recovery Funds con l’esultanza di una vittoria sportiva, trasformando in un derby calcistico la contrapposizione tra la nostra perenne, famelica brama di sussidi e le legittime riserve dei paesi definiti (quasi sprezzantemente) “frugali”. Di più: quasi come un atto riparatore contro i colpi di un imprevedibile destino, cinico e baro, che ha colpito l’Italia (non piuttosto delle scelte dissennate dei suoi cittadini) oppure, peggio, una rivalsa morale contro le manovre oscure di immaginari nemici esterni. Il paese dove molti già scalpitano pensando a come utilizzare le risorse che l’Europa sembra intenzionata a destinarci, ignorando intanto il cappello che abbiamo dovuto porgere per ottenerle. Dove le menti si ingegnano e le idee frullano. Finalmente potremo spendere liberamente, archiviando la stagione di un’austerità in realtà inventata – numeri alla mano – ma comodo alibi per giustificare tutte le nostre deficienze con la narrativa dei vincoli esterni. È in arrivo una nuova diligenza da assaltare, tanto che qualcuno ha già vagheggiato l’abbassamento delle tasse e qualcun altro si è spinto a proporre la creazione di un fondo sovrano in cui far confluire questa nuova ricchezza, da gestire secondo i bisogni, in maniera pianificata. Proprio come la Norvegia, dicono.
Peccato che questa inattesa “ricchezza”, nel nostro caso, è debito. O al massimo un sostegno di terzi a fondo perduto. Non sono, cioè, risorse prodotte nel paese e non sono neppure provenienti da chissà quale giacimento di materie prime. Sono debito. Se non contabile, almeno morale. Ad un paese in cui le famiglie si sono arricchite con l’indebitamento pubblico, finanziando con esso un livello di consumi superiore al reddito prodotto e in cui una gigantesca operazione ventennale distributiva di risorse (generate con la stampa di cambiali) ha contribuito a costruire per magia le leggende sull’autoproclamata “quinta potenza economica mondiale”, la linea di demarcazione tra ricchezza e debito deve tuttavia apparire irrimediabilmente sfocata.
In Norvegia lo Stato ha risparmiato per preservare il benessere delle future generazioni. In Italia lo Stato ha speso, lasciando il debito sulle spalle delle future generazioni che inevitabilmente lo pagheranno (esplicitamente sotto forma di tasse o implicitamente sotto forma di perdita di opportunità, risorse, crescita economica). Ma ora le generazioni che negli anni ’80 e ‘90 dovevano ancora venire sono arrivate e stanno già pagando. È davvero così difficile notare la differenza?
Naturalmente qualcuno obietterà che le risorse pubbliche, trasferite in misura così massiccia dallo Stato (con il meccanismo descritto, che ha indebitato lo Stato e i suoi futuri contribuenti) sono state risparmiate dalle famiglie in forma di case, risparmi in banca (o sotto i materassi), pensioni dei genitori che nel frattempo sono diventati nonni e che hanno pagato gli studi a figli e nipoti, comprato l’appartamento quando i figli si sono sposati. Oppure hanno lasciato case, che sono state poi trasferite e ristrutturate essendo oggi beni materiali in mano alle nuove generazioni. Questa obiezione è valida solo in minima parte, per due ragioni.
Anzitutto, il meccanismo dell’accumulazione di risparmio non ha beneficiato tutti in maniera proporzionale, mentre il debito pubblico colpisce tutti senza distinzione. Non tutti i cittadini attivi di oggi hanno avuto genitori e nonni in grado di risparmiare e comunque non tutti hanno svolto attività economiche in grado di alimentare gli stessi livelli di risparmio. Poi ci sono differenze prodotte dalle scelte individuali. L’appartamento ereditato dal nonno nel centro di Milano non ha acquistato negli anni lo stesso valore di uno nel centro di Roccacannuccia. Questa distorsione evidente nella distribuzione dei proventi del debito (mentre l’onere rimane inevitabilmente socializzato) produce come risultato inevitabile un freno alla mobilità di classe della società italiana, un limite all’efficacia del merito come fattore incentivante e una zavorra sulla produttività del lavoro.
In secondo luogo, questa diffusione capillare del risparmio, in un Paese con scarsa cultura del mercato, ha finito per destinare le risorse su impieghi ritenuti “sicuri” (la casa, i titoli di stato, la seconda casa) limitando fortemente il potenziale di moltiplicazione delle risorse, penalizzandone gli impieghi produttivi.
Ma torniamo alla Norvegia. Il Fondo Sovrano detiene 9.202 partecipazioni in 74 paesi. Volete sapere quante, tra queste, sono aziende norvegesi? Zero. Se il fondo potesse intervenire direttamente nell’economia nazionale, si trasformerebbe in una grande centrale dirigista capace di condizionare pesantemente le scelte economiche, di spiazzare gli investimenti privati, di condurre ogni forma di merito sotto il controllo della mano pubblica. Magari si metterebbe a salvare aziende in difficoltà, azzerando il rischio imprenditoriale e creando un gigantesco sistema di azzardo morale. Un pericolo che la classe politica norvegese si è preoccupata di scongiurare.
Il socialismo norvegese ha insomma rinunciato alla tentazione di controllare l’economia, mentre il socialismo alle vongole veraci non perde l’occasione per denunciare a gran voce i guasti del cosiddetto neoliberismo, mentre intanto si stampa debito e si preleva ogni anno metà del prodotto nazionale per tenere in piedi il più costoso sistema pensionistico europeo. O per tenere in vita, in nome dei “livelli occupazionali”, aziende decotte come Alitalia, sottratte all’iniziativa privata come Ilva o prive di senso economico come Atac: enti falliti, incapaci di fornire perfino i servizi più basilari previsti dalla loro mission mentre bruciano le tasse dei contribuenti.
Detenendo una quantità così elevata di partecipazioni, il fondo norvegese non acquisisce quote rilevanti di alcuna società. In pratica, non arriva mai oltre l’1 o il 2% del capitale, rinunciando così a qualsiasi forma di influenza rilevante. È un investimento esclusivamente finanziario e tale deve restare, senza tentazioni di politica industriale, senza farsi tirare la giacchetta da azionisti privati interessati a scalare società formando cordate o architettando patti di sindacato. Senza posti nei consigli di amministrazione e senza golden shares. Senza farsi, cioè, condizionare da obiettivi che possano travisare l’unica mission del fondo: preservare e valorizzare la ricchezza dei cittadini.
Tutto questo deve sembrare bizzarro ai cittadini del paese che ha avuto l’IRI, l’EFIM e che ha fatto della Cassa Depositi e Prestiti un gigantesco fondo di private equity con finalità di controllo politico.
La creazione di un fondo sovrano è considerato dalla teoria economica un rimedio classico a quello che va sotto il nome di Male Olandese (Dutch Disease). Si ritiene cioè che, in un sistema economico, l’improvviso aumento del reddito causato dalla scoperta di giacimenti naturali rischi di spostare investimenti finanziari e capitale umano verso il settore minerario o estrattivo, drenandole dal settore manifatturiero che potrebbe così impoverirsi. Prospettando contratti di lavoro vantaggiosi grazie alla redditività elevata di cui dispone, il settore più florido inizierà a calamitare addetti che abbandoneranno gli impieghi nel settore industriale (o nell’agricoltura) per sfruttare le nuove opportunità.
Sono fenomeni che abbiamo sperimentato anche in Italia, a livello di comunità locali, in molte realtà che hanno dovuto confrontarsi con la crisi di un’azienda (o di un’industria) dopo anni di vacche grasse (da Siena, con la sua banca, a Terni con le acciaierie, fino al tessile di Prato). In queste situazioni, si ritiene che il dosaggio lento e controllato delle nuove risorse nel circuito economico (come può avvenire attraverso la regolazione di un fondo sovrano) prevenga la desertificazione industriale che potrebbe conseguire alla crisi dell’industria di riferimento. Al contrario, se il fondo intervenisse direttamente nell’economia potrebbe vanificare questo rimedio, riverberando il Male Olandese, attraverso gli investimenti in alcune aziende invece che in altre. Le distorsioni della concorrenza interna sarebbero devastanti.
Il Fondo Norvegese contribuisce anche al bilancio dello Stato (coprendo all’incirca il 20% del fabbisogno) destinandovi annualmente una quota controllata delle risorse gestite (non più del 3%-4%). Questo meccanismo consente al governo di regolare la politica fiscale e di finanziare investimenti pubblici, ma nessuno ha mai pensato di erogare bonus, sussidi straordinari o detassazioni. Nella politica di erogazione del fondo, descritta nel suo sito, si legge: “Esiste un vasto consenso su come il Fondo debba essere gestito. Spendendo meno oggi, saremo in una posizione migliore domani per affrontare crisi e recessioni future. Gli avanzi del bilancio pubblico vengono trasferiti al fondo, mentre i deficit sono coperti con erogazioni del fondo. In altre parole: le autorità possono spendere di più negli anni difficili e meno negli anni buoni. Per consentire a più persone possibile di beneficiare del fondo nel futuro, i politici hanno concordato una regola fiscale che impedisce di spendere in misura superiore ai ritorni attesi dal fondo. In media, il governo dovrà spendere solo l’equivalente del rendimento reale del fondo, stimato intorno al 3% annuo. Al tempo stesso, solo il rendimento del fondo può essere speso. Non il suo capitale”.
Conclusione. La Norvegia è un paese di 5 milioni di abitanti, ognuno dei quali dispone di una ricchezza di 200 mila dollari gestita dallo Stato. L’Italia è un paese di 60 milioni di abitanti, ognuno dei quali ha un debito di 50 mila dollari gestito dallo Stato. Certo, la Norvegia ha trovato il petrolio e l’Italia no. Ma si potrebbe obiettare che l’Italia ha avuto ben altro petrolio dalla sua storia rispetto alla Norvegia e che una differenza così radicale nella posizione finanziaria pubblica sia stata prodotta, soprattutto, dalla diversa qualità delle scelte politiche fatte dai cittadini dei due paesi, che riflettono un approccio totalmente diverso all’etica pubblica.








