Making a Murderer, appunti per la giustizia italiana
Diritto e libertà
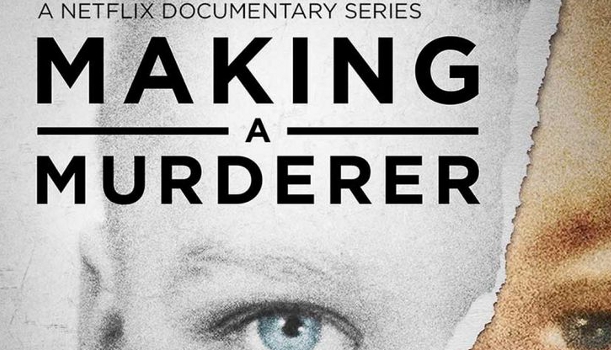
“Making a murderer” è una fortunata docu-serie prodotta da Laura Ricciardi e Moira Demos, trasmessa in Italia da dicembre su Netflix. L’ambientazione è quanto di più lontano ci sia dal Belpaese: Manitowoc, Wisconsin. Boschi, camicie a quadri, caccia e pick-up. La serie racconta la storia di Steven Avery, portandola di fronte agli occhi del mondo e ponendo molti interrogativi sul concetto di giustizia.
Avery era un giovane sfasciacarrozze nell’attività di famiglia, quando a 23 anni venne condannato per lo stupro di Penny Beerntsen. Un riconoscimento facciale sbagliato, qualche piccolo precedente e un rancore accumulato nei suoi confronti dalla polizia locale lo portarono a passare 18 anni dietro le sbarre. Solo nel settembre 2003 verrà liberato in seguito ad una ripetizione del test del DNA. Nel frattempo Avery si è giocato tutta la sua gioventù in galera.
Non passano neanche due anni e l’innocente liberato non fa in tempo a chiedere un risarcimento che viene arrestato di nuovo, questa volta con un’accusa più grave: lo stupro e l’omicidio di Teresa Halbach, giornalista per un magazine di automobili che ha visitato la sua autorimessa ed è stata poi data per dispersa. I suoi resti verranno trovati, carbonizzati, in tre diversi luoghi all’interno e all’esterno della proprietà degli Avery. Lì anche la sua auto, con tracce di sangue di Steven, che tuttavia non mostrava alcuna ferita.
Non vogliamo “spoilerare” (l’abbiamo in parte già fatto) e rivelare i dettagli della strategia difensiva e l’esito della sentenza, ma il caso di Steven Avery, come tanti altri, apre alcune riflessioni sull’amministrazione della giustizia, sull'azione dei pubblici ministeri e delle forze di polizia e sul ruolo dei media nelle vicende giudiziarie.
Nonostante i 7000 km di distanza tra l’Italia e il Wisconsin, si trovano tanti parallelismi con la vicenda narrata in “Making a murderer”, che sarebbe passata sotto silenzio se non fosse diventata un documentario, e tanti casi giudiziari italiani. Nelle auto della polizia che nel 1985 arrivano da Steven Avery prima ancora che si controllino gli spostamenti di persone con precedenti per stupro, c’è la stessa mentalità di fondo che emerge da una frase come “Uva, proprio te stavo cercando”, smentita da agenti e Procura, ma che, secondo il teste Alberto Biggiogero, un carabiniere avrebbe pronunciato fermando Giuseppe Uva, morto di lì a qualche ora, dopo il trasferimento dalla caserma di via Saffi all'ospedale di Circolo, a Varese, il 13 giugno 2008. I toni dell’interrogatorio dello stesso Biggiogero ricordano per certi versi quello di Brendan Dassey, nipote di Avery, con un QI sotto la media e spinto a fornire agli inquirenti la deposizione che essi volevano da lui, per confermare la propria ipotesi accusatoria.
Allo stesso modo, l’identikit di Avery del 1985, disegnato sulla base di una foto segnaletica già presente e sottoposta alla vittima senza che questa aiutasse le forze dell’ordine a disegnare i connotati dell’assalitore, in qualche modo rimanda al video “tarocco” contro Massimo Bossetti, di cui il comandante dei Ris giustificò così il confezionamento: "Questo video è stato concordato con la Procura" ed è "stato fatto per esigenze di comunicazione."
Accade troppo spesso che autorità giudiziaria, forze dell’ordine e media trascurino garanzie e regole per la fretta di servire un colpevole in pasto all’opinione pubblica e per non dare l'impressione di brancolare nel buio. Certo, è legittimo e doveroso avere sospetti e raccogliere prove, ma non bisognerebbe farsi fuorviare dalla pressione di giornali e tv, che lucrano sulla cronaca nera, seguendo interessi di ascolto e di introito, non di giustizia.
Del resto, guardando “Making a murderer”, la domanda sorge spontanea. TV e giornali sollevano attenzioni ossessive sui casi di cronaca, distorcendo o sorvolando sui fatti, perché il loro mestiere non è raccogliere elementi di prova, nel rispetto della garanzia degli indagati, o accertare la fondatezza di un'accusa, nel rispetto delle regole dei codici, ma rendere i casi mediaticamente più "sexy", quindi più scandalosi, morbosi e pregiudizialmente accusatori, proprio per raccogliere più audience. Ma non è una serie TV essa stessa un media, che propone una visione parziale del processo?
Senz’altro. Tuttavia Ricciardi e Demos, insieme agli avvocati di Avery, sono brave ad instillare il seme del sospetto e a far sorgere delle domande negli spettatori, portandoli a meditare sui rischi di una giustizia sommaria. Occorrerebbe meditare meglio, in Italia, con qualche punto interrogativo in più nelle prime pagine, su cui vengono sbattuti i mostri ad uso e consumo dell’indignazione collettiva, in una ricerca di colpevoli dove si finisce quasi sempre, prima o poi, per dimenticare le vittime.








