I diritti acquisiti? Sono sussidi fiscali. Ad esempio, sulle pensioni...
Maggio 2014 / Monografica
Quando parliamo di diritti acquisiti, ci riferiamo all'esigenza di rispettare il presupposto giuridico pubblico dell'attività economica privata, o al contrario ci riferiamo alla necessità di garantire sussidio economico pubblico alla condizione giuridica di alcuni privati, a danno di altri? In Italia, soprattutto in materia previdenziale, sembra verificarsi la seconda, non la prima ipotesi.
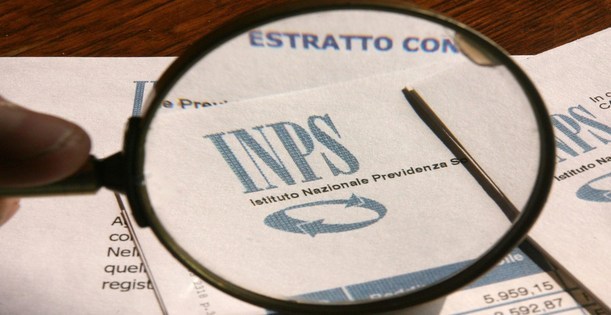
Tutti conosciamo i motivi che rendono difficile l'attuazione delle riforme nel nostro paese; in alcuni settori, tuttavia, ci si scontra contro un vero e proprio muro giuridico, un ostacolo insormontabile e gattopardesco: i diritti quesiti (o acquisiti), ossia diritti che, una volta entrati nella sfera giuridica di un soggetto, si considerano immutabili anche di fronte a eventuali modificazioni legislative successive.
Il caso più eclatante di diritti acquisiti è quello relativo al sistema pensionistico. Che le pensioni costituiscano una fetta notevole della spesa pubblica italiana non è certo una novità: quasi 250 miliardi all'anno, con un incremento di 22 miliardi negli ultimi quattro anni e, secondo le previsioni dell'OCSE, ulteriori 8 miliardi in più nei prossimi due. Numeri impressionanti, che assegnano all'Italia il primato europeo di spesa previdenziale rispetto al PIL (16%) e che, soprattutto, sono retti solo in minima parte dai contributi versati nei decenni passati, quando il regime retributivo e scellerate riforme acchiappa-voti (baby pensioni e pensioni d'oro su tutte) hanno posto le basi per la situazione odierna, con i soldi dei contribuenti a tappare il buco e la vertiginosa crescita del debito pubblico a rimandare, e aggravare, il problema.
Alla fine, la riforma Fornero ha, come si usa dire, messo in sicurezza il sistema sul piano della sostenibilità finanziaria, ma non ha affatto risolto, anzi, per certi versi ha aggravato il problema della sua equità interna, poiché ha scaricato pressoché integralmente sui contribuenti non ancora pensionati l'onere dell'aggiustamento, e malgrado gli indubbi risparmi conseguiti non ha riallineato a standard europei il peso della spesa previdenziale sul totale della spesa sociale e di quella pubblica in generale.
È logico, di conseguenza, che il sistema previdenziale rientri nel dossier delle riforme possibili anche per il futuro. Da ultimo si è ipotizzato il ritocco delle pensioni d'oro (quelle, cioè, superiori ai 3000 Euro mensili, che coprono poco più del 5% dei pensionati ma assorbono il 17% della spesa previdenziale, per un totale di ben 45 miliardi annui). Ma anche in questo caso occorrerà fare i conti con i diritti acquisiti e con il loro uso politico. In primo luogo, quando parliamo di diritti acquisiti, ci riferiamo all'esigenza di rispettare il presupposto giuridico pubblico dell'attività economica privata, o al contrario ci riferiamo alla necessità di garantire sussidio economico pubblico alla condizione giuridica di alcuni privati, a danno di altri? In Italia, soprattutto in materia previdenziale, sembra verificarsi la seconda, non la prima ipotesi.
Nel testo della Costituzione i diritti acquisiti non vengono nominati. A ben vedere, tuttavia, si tratta di un silenzio tutt'altro che casuale: durante i lavori dell'Assemblea costituente, infatti, l'on. Dominedò propose di inserire nell'articolo 25 della Carta la non retroattività della legge nei confronti dei diritti quesiti. All'idea che l'irretroattività della legge dovesse assurgere a principio generale, l'Assemblea costituente si oppose duramente, constatando la mobilità che caratterizza i diritti sociali e l'importanza di non cristallizzare situazioni presenti che nel futuro, al mutare di alcune condizioni, avrebbero potuto risultare inique. Di conseguenza, l'emendamento non fu approvato e i diritti acquisiti furono esclusi dalla tutela dell'articolo 25, che sancisce il principio di irretroattività solo per le norme penali. Resta l'articolo 11 delle preleggi, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Le preleggi, però, sono norme di rango ordinario e, pertanto, suscettibili di deroga da parte di norme di rango pari o superiore.
La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la propria apertura alla promulgazione di norme retroattive, estesa più volte anche al campo dei trattamenti pensionistici o retributivi: la sentenza n. 441 del 12 novembre 2002, ad esempio, dispone che il legislatore possa, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, ridurre trattamenti pensionistici già in atto, non certo limitando del tutto il diritto a una pensione legittimamente attribuita, ma introducendo una disciplina non irragionevolmente più restrittiva.
Alla prova dei fatti, tuttavia, introdurre "una disciplina non irragionevolmente più restrittiva" non è riuscito a nessuno. Nemmeno alla Fornero che, nel 2011, introdusse un "contributo di solidarietà" alle pensioni sopra i 90.000 Euro lordi annui, dichiarato illegittimo dalla Corte per violazione del principio di parità di trattamento. Le proposte di taglio dei tetti degli stipendi dei dirigenti pubblici, anch'esse rientranti a pieno titolo tra le ricette evergreen della spending review, hanno peraltro incontrato a più riprese (e, con ogni probabilità, continueranno a incontrare) lo stesso problema.
La cautela della Corte è volta, comprensibilmente, a difendere il principio di certezza del diritto. Nel caso specifico, il taglio alle pensioni più alte rischia di creare una vera e propria discriminazione della ricchezza in sé e per sé. Nessun dubbio, per intenderci, sul fatto che chi ha versato per tutta la vita contributi previdenziali elevati meriti per intero la sua "pensione d'oro". E poi, chi decide quali pensioni sono "d'oro" e quali no? E su che basi? Questi i pericoli che la Corte Costituzionale paventa con le sue pronunce. Pericoli che si applicano perfettamente anche agli stipendi dei dirigenti pubblici.
D'altra parte, è difficile non riconoscere che nelle pensioni maturate con il metodo retributivo - cioè quelle generalmente corrisposte - opera un sussidio fiscale implicito e permanente a vantaggio del percettore. Da questo punto di vista, tale sussidio non può considerarsi giuridicamente più "acquisito" di un altro di identica natura, ad esempio quello alla detraibilità di determinate spese. Se però nessuno mette in dubbio che di anno in anno, sulla base di considerazioni generali di finanza pubblica, il sussidio implicito in una detrazione possa mutare, perché non può mutare quello relativo a un trattamento pensionistico? A ben guardare, emerge chiaramente come i diritti acquisiti siano il frutto non di un accordo di tipo contrattuale tra lo Stato e i cittadini, ma di scelte generali di politica economica e sociale.
Ad esempio, posto che un sussidio al reddito individuale si giustifichi quando sia finalizzato ad evitare che determinati contribuenti scendano sotto la soglia di povertà assoluta e a garantire che siano in grado di soddisfare i bisogni primari, lo stesso sussidio non trova più (questa) giustificazione quando serva a garantire al beneficiario una certa continuità di reddito, a prescindere dal suo ammontare. In genere, i benefici fiscali decrescono al crescere del reddito del percettore, nelle pensioni invece rimangono immutati perché il reddito del percettore non decresca. Anche volendo rimanere dentro una logica "sociale" molto tradizionale, non c'è un'evidente contraddizione?
La Corte Costituzionale ritiene che i tagli alle pensioni d'oro ledano la parità di trattamento o costituiscano un abuso di discrezionalità? Ebbene, ovviamente bisogna evitare di generalizzare e operare gli opportuni distinguo. Anche per fare ciò, bisognerebbe però uscire al più presto dall'inganno retorico secondo il quale la tutela dei diritti acquisiti abbia comunque un valore sociale e serva a proteggere le categorie più deboli: non sempre, anzi, molto raramente, è davvero così.
INDICE Maggio 2014
Editoriale
Monografica
- Uno "Stato di mercato". Prezzi e concorrenza, per una riforma liberale della P.A.
- Il grande inganno della spesa pubblica
- I diritti acquisiti? Sono sussidi fiscali. Ad esempio, sulle pensioni...
- Chi ha fatto sul serio coi tagli di spesa?
- Guardiamola in faccia, questa spesa pubblica
- Approfondimento #1: Servizi generali, difesa e ordine pubblico
- Approfondimento #2: Istruzione
- Approfondimento #3: Sanità
- Approfondimento #4: Protezione sociale
- Approfondimento #5: Sussidi e affari economici
- Approfondimento #6: Ambiente, territorio, cultura
Istituzioni ed economia
- Pelù e il talent politico del Concertone
- Valls ricorda Renzi, ma anche Sarkozy. La possibile Terza Via alla francese
- Tutti parlano di Europa, ma nessuno ha ancora risposto a Erodoto
Innovazione e mercato
Scienza e razionalità
- Terremoto in Emilia e trivelle: che cosa dice (davvero) la scienza
- Dall'allarmismo allo scetticismo. Il senno di poi sull'aviaria
Diritto e libertà
- Il prezzo della libertà è l'eterna sorveglianza (di massa)?
- Carceri, il prezzo (materiale) dell'illegalità
Terza pagina









